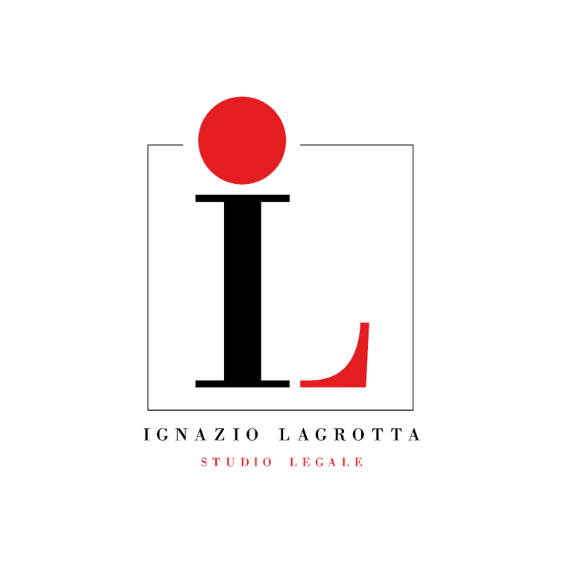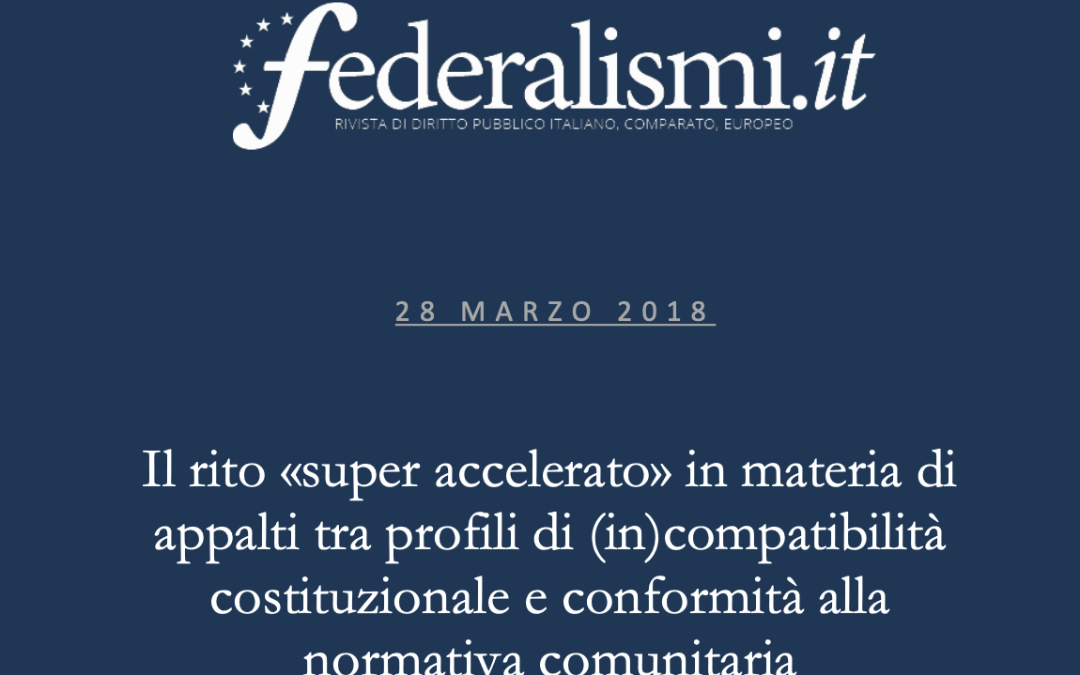La disciplina degli appalti pubblici “lambisce” un nervo sempre molto sensibile che inevitabilmente coinvolge il sistema economico del Paese1. Da un lato essa è chiamata a garantire i precetti costituzionali di efficienza, efficacia ed economicità; questi tramite le procedure di scelta del contraente, spesso in maniera più declamata che attuata, dovrebbero portare alla selezione della migliore offerta possibile sul mercato. Dall’altro si occupa di disciplinare la fase dell’esecuzione del contratto d’appalto che dovrebbe garantire in tempi certi e risorse prestabilite la perfetta esecuzione dell’opera. Orbene volendosi soffermare sull’ultimo ventennio, partendo dalla L. n. 109/1994 (la c.d. Merloni) e dal vecchio regolamento di esecuzione il R.D. 25 maggio 1895 n. 350 sino al nuovo codice degli appalti ed alle recenti modifiche, vani appaiono i tentativi di risolvere proceduralmente un problema che è innanzitutto di etica pubblica2 (non di morale). Mi spiego meglio, le patologie che affliggono la fase di scelta del contraente non sembra che siano state superate dalla girandola di preferenze che il nostro sistema legislativo ha nel tempo attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa oggi o al prezzo più basso nel recente passato. Allo stesso modo non sono state risolte con l’esclusione automatica delle offerte anomale o con l’obbligatorietà della verifica di anomalia.